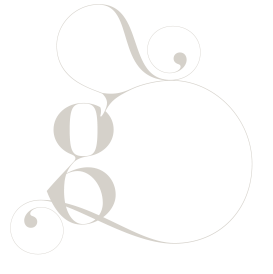The Beauty of Authenticity
March 18, 2025
A Presence Without Origin
April 6, 2025

The elegant reinterpretation of masculine fashion by women has gained increasing attention in recent years—recalling the legacy of Saint Laurent’s tailored suits and the subtle power of dandy elegance. From Bella Hadid’s sharp-shouldered tuxedo at the YSL fashion show to Cate Blanchett’s fluid tailoring on international red carpets, the suit continues to evolve as a form of visual self-possession. In both cases, the figure is less about concealment and more about command; a delicate structure that frames the body without yielding it.This piece explores the dynamic between strength and softness, between form and identity, and the ways women reshape traditionally masculine codes to tell their own story.
The leisure of creating one’s own standards, and forming one’s own narrative of what defines ‘beauty’, has reached a new maturity. The modern age, thanks to the melting of rigid gender characteristics, has arrived at a point where it is no longer revolutionary for women to dress in suits—but rather an act of refined self-expression. In today’s world, self-expression—whether in fashion, lifestyle, or sexuality—is not just accepted but expected. It is understood that when one dares to be fully seen, even exposed to criticism, one becomes magnetic. And through that magnetism, others begin to follow.
In modern society, femininity and masculinity are no longer seen as strict opposites, but as fluid concepts that can be intertwined, layered, and redefined. And what emerges is something more powerful than the binary: a personal aesthetic language.
I have always loved borrowing male clothing. I still remember the early experiments—styling my father’s tailor-made jackets with belts cinched at the waist. I discovered something unexpected: my silhouette appeared more delicate, more graceful, than it ever did in floral blouses or silk dresses. That discovery led to a question that still lingers: does a woman gain or lose her feminine power when dressed in masculine clothing?
This question echoes beyond style—it touches on perception, and even the psychology of beauty. Susan Sontag, in her essays on aesthetics, suggested that what’s most beautiful in the feminine is often something masculine, and vice versa. In other words, contrast deepens character. What she hints at is that beauty, in its most lasting form, comes from the unexpected, from the tension between identity and illusion. It may be this very contradiction that creates presence. When tailored pieces once designed for male authority are worn by women, the result isn’t rebellion. It’s refinement.
Clothing is a part of identity, an externalisation of internal choices and values. Society still applies subtle pressure to align with expectations, but today, those expectations are more fragmented. When a woman wears a suit, she does not sacrifice femininity, but she actively reframes it, as she occupies both softness and attitude at once.
And this brings us to the deeper reflection.
The goal is not merely to revive masculine tailoring, but to deconstruct the old romanticism and examine the new—this time with a relaxed, almost playful elegance. The question arises: can female sensuality outgrow the restraint once imposed by male-coded style, and re-emerge, liberated, through it?
In this context, the suit becomes more than a garment. It becomes a medium through which the inexhaustible theme of eroticism is revisited. Not overtly, but in whispers. A quiet dialogue unfolds, testing the idea that what has long been repressed will always seek form—that concealed sensuality must find a way to express itself. And perhaps that is the nature of eroticism itself: it resists clarity. It invites pursuit. It hides in contrast, waits in structure, and when discovered in contradiction—it leaves its most lasting impression. Not on the eye, but on the sensitive observer.
As Giorgio Armani once said, “Elegance is not about being noticed, it’s about being remembered.” And perhaps, it is this dialogue between softness and strength that allows elegance, too, to evolve.
La reinterpretazione elegante della moda maschile da parte delle donne ha acquisito una crescente rilevanza negli ultimi anni—richiamando l’eredità degli abiti sartoriali di Saint Laurent e il potere sottile dell’eleganza dandy. Dal tuxedo dalle spalle scolpite indossato da Bella Hadid alla sfilata di YSL, fino ai completi morbidi e strutturati portati da Cate Blanchett sui red carpet internazionali, l’abito continua a evolversi come una forma di autodeterminazione visiva. In entrambi i casi, la figura comanda; è una struttura elegante che incornicia il corpo senza cederlo. Questo testo esplora la dinamica tra forza e delicatezza, tra forma e identità, e il modo in cui le donne ridisegnano codici tradizionalmente maschili per raccontare la propria storia.
Il piacere di creare i propri standard, e di costruire una narrativa personale su cosa definisca la “bellezza”, ha raggiunto una nuova maturità. L’età moderna, anche grazie alla dissoluzione delle rigide caratteristiche di genere, è giunta a un punto in cui non è più rivoluzionario per una donna indossare un completo—ma piuttosto un atto di raffinata autoespressione. Nel mondo di oggi, l’autoespressione—che si tratti di moda, stile di vita o sessualità—non è solo accettata, ma attesa. È noto che solo quando si ha il coraggio di mostrarsi per ciò che si è, anche a costo di ricevere critiche, si diventa magnetici. Ed è proprio attraverso quel magnetismo che gli altri iniziano a seguire.
Nella società contemporanea, femminilità e mascolinità non sono più viste come opposti netti, ma come concetti fluidi, intrecciati, stratificabili. E ciò che ne emerge è qualcosa di più potente del binarismo: un linguaggio estetico personale.
Ho sempre amato prendere in prestito abiti maschili. Ricordo ancora i miei primi esperimenti—giacche sartoriali di mio padre abbinate a cinture in vita. Scoprii qualcosa di inatteso: la mia silhouette sembrava più delicata, più aggraziata, di quanto apparisse con bluse floreali o abiti di seta. Da quella scoperta nacque una domanda che ancora oggi persiste: una donna perde o acquisisce forza femminile quando indossa un completo maschile?
Una domanda che va oltre lo stile: tocca la percezione, la presenza e persino la psicologia della bellezza. Susan Sontag, nei suoi saggi sull’estetica, suggeriva che ciò che è più bello nel femminile è spesso qualcosa di maschile—e viceversa. In altre parole, il contrasto intensifica il carattere.
Ciò che lei suggerisce è che la bellezza, nella sua forma più duratura, nasce dall’inaspettato—dalla tensione tra identità e illusione. È forse proprio questa contraddizione a generare presenza. Quando un capo sartoriale, pensato per rappresentare autorità maschile, viene indossato da una donna, il risultato non è ribellione. È raffinatezza.
L’abbigliamento è parte dell’identità, un’esternalizzazione delle proprie scelte e dei propri valori. La società continua a esercitare pressioni sottili per adeguarsi alle aspettative, ma oggi queste aspettative sono più frammentate. Quando una donna indossa un completo, non sacrifica la propria femminilità—la ridefinisce. Occupa allo stesso tempo la morbidezza e la struttura.
Ed è qui che si apre una riflessione più profonda.
Lo scopo non è semplicemente riportare in auge il tailoring maschile, ma decostruire il vecchio romanticismo ed esaminarne uno nuovo—questa volta con un’eleganza più rilassata, quasi giocosa. Sorge la domanda: può la sensualità femminile superare con leggerezza la costrizione storicamente imposta dallo stile maschile, e riemergere, libera, attraverso di esso?
In questo contesto, il completo diventa più di un capo. Si fa mezzo per riprendere il tema inesauribile dell’erotismo. Non in modo esplicito, ma in sussurri. Un dialogo silenzioso si sviluppa, mettendo alla prova l’idea che ciò che è stato a lungo represso cercherà sempre una forma—che la sensualità nascosta debba trovare il modo di esprimersi. E forse è proprio questa la natura dell’erotismo: sfuggente per definizione. Invita alla ricerca. Si cela nel contrasto, attende nella struttura, e una volta scoperto nella contraddizione—lascia l’impressione più duratura. Non sull’occhio, ma sull’osservatore sensibile.
Come disse Giorgio Armani: “L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare.” Forse è proprio questo dialogo tra contenimento ed espressione—tra morbidezza e rigore—a permettere all’eleganza di evolvere.