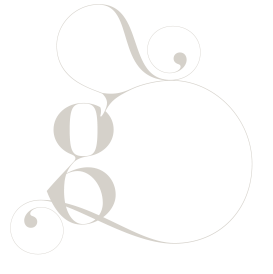The Memory Refused to Wake
July 28, 2025
August Issue
August 17, 2025

Living inside an old film, I wandered the familiar streets of a Mediterranean town where façades wore the sun like a faded costume, and every shadow felt rehearsed. The air held the quiet of places that had once been central to someone’s life, though whose life it was remained unstated.
Somewhere between a columned arcade and the hush of a small piazza, I thought about those making fashion intellectual, and intellectuals fashionable. About the phenomenon of good taste, that fragile distinction forever in opposition to the theatrical excess of kitsch. Whether it is inherited—passed down like a title of nobility, carrying the same invisible obligations—or acquired through the etiquette of travel: moving through capitals, studying gestures, absorbing atmospheres sanctioned by institutions.
But once I reached this point of view, another question unsettled me: if taste can be learned, is it ever truly one’s own? And if inherited, can it escape the weight of origin? Perhaps the purest form of elegance lies not in proving taste, but in resisting the need to display it at all.
Mediterranean palace, being as ancient as time, whispers the logic where nothing seemed to obey the urgency of the present; colours had faded without replacement, and the windows displayed the same objects year after year—not from neglect, but from conviction. If trends are the currency of the visible season, then taste is the private ledger, kept without announcement, immune to the fluctuations of the calendar. Sontag once called kitsch a love of the unnatural, the desire to make something more than it is; taste resists that urge, allowing things—fabrics, proportions, colours—to remain as they are, without pleading for attention.
Yet the closer one observes, the more refinement itself begins to resemble a performance—an arrangement of signals no less coded than the changing hems and colours of a runway. Barthes would have called it a language: a network of signs in which a hemline, a collar, or even the absence of ornament speaks in its own syntax. Which is why it is possible to sense when a look is fluent in this language, and when it is merely repeating its vocabulary without understanding the grammar.
It was then I caught the quiet irony of Didion’s kind—that even the most uncalculated elegance can, in the wrong company or the wrong light, look staged. That perhaps what we call authentic taste is only the brief harmony between what one chooses and the moment that receives it. The film reel keeps running, and I am left unsure whether I belong to its story, or am only passing through its set.
So I am left to wonder whether cultivation is ever a stable possession, or if it is only a fleeting alignment between what we choose and how the world happens to see it in that moment. Perhaps it is less a matter of having taste than of knowing when to let it vanish into the background, unannounced—though even that, I admit, may only be another form of display.
Vivere all’interno di un vecchio film, mi ritrovai a camminare per le strade familiari di una città mediterranea dove le facciate indossavano il sole come un costume sbiadito e ogni ombra sembrava provata in anticipo. L’aria custodiva il silenzio di luoghi che un tempo erano stati centrali nella vita di qualcuno, anche se di chi fossero restava non detto.
Tra un portico colonnato e il silenzio di una piccola piazza, pensai a chi cerca di rendere la moda intellettuale e gli intellettuali alla moda. Al fenomeno del discernimento estetico—quella fragile distinzione sempre in opposizione all’eccesso teatrale del kitsch. Se sia qualcosa di ereditato—trasmesso come un titolo nobiliare, con le stesse obbligazioni invisibili—o acquisito attraverso il galateo del viaggio: muovendosi tra capitali, studiando gesti, assorbendo atmosfere sancite dalle istituzioni.
Ma giunta a questo punto di vista, un’altra domanda mi turbò: se la sensibilità può essere appresa, è mai davvero propria? E se ereditata, può sfuggire al peso dell’origine? Forse la forma più pura di eleganza sta non nel dimostrare la raffinatezza, ma nel resistere al bisogno di esibirla.
Il palazzo che attraversai—mediterraneo nella sua imponenza, antico quanto il tempo—sembrava sussurrare una logica in cui nulla obbediva all’urgenza del presente. I colori si erano sbiaditi senza essere sostituiti, e le vetrine esponevano da anni gli stessi oggetti—non per trascuratezza, ma per convinzione. Se le tendenze sono la valuta della stagione visibile, allora la coltivazione del gusto è il registro privato, mantenuto senza annunci, immune alle oscillazioni del calendario. Sontag definì il kitsch un amore per l’innaturale, il desiderio di rendere qualcosa più di ciò che è; il discernimento resiste a questo impulso, lasciando che le cose—tessuti, proporzioni, e colori—restino come sono, senza supplicare attenzione.
Eppure, più osservavo da vicino, più la raffinatezza cominciava a somigliare a una performance—un insieme di segnali non meno codificati degli orli e delle tonalità che cambiano in passerella. Barthes l’avrebbe chiamato un linguaggio: una rete di segni in cui un orlo, un colletto o persino l’assenza di ornamento parlano con una loro sintassi. Ecco perché è possibile percepire quando uno sguardo è fluente in questo linguaggio e quando invece ripete solo il vocabolario senza comprenderne la grammatica.
Fu allora che colsi l’ironia sommessa—quella di Didion—secondo cui anche l’eleganza più non calcolata può, nella compagnia o nella luce sbagliata, sembrare costruita. Che forse ciò che chiamiamo gusto autentico non è altro che la breve armonia tra ciò che si sceglie e il momento che lo accoglie. La pellicola continua a scorrere, e io resto incerta se appartengo alla sua storia o se sto soltanto attraversando il set.
Così mi domando se la coltivazione del gusto sia mai un possesso stabile, o se sia soltanto un allineamento fugace tra ciò che scegliamo e come il mondo decide di vederlo in quell’istante. Forse non si tratta tanto di avere sensibilità quanto di sapere quando lasciarla scomparire sullo sfondo, non annunciata—anche se, lo ammetto, potrebbe essere anch’essa un’altra forma di messa in scena.